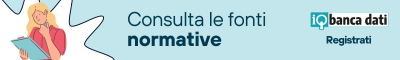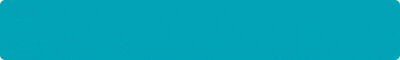Qualificazione del rapporto di lavoro dei rider
Può essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limita a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa (Cassazione - sentenza 31 ottobre 2025 n. 28772)
Qualificazione del rapporto di lavoro dei rider
Può essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limita a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa (Cassazione - sentenza 31 ottobre 2025 n. 28772)
Nella specie, alcuni lavoratori che avevano lavorato presso una società in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, adivano il Tribunale di primo grado per ottenere, tra l'altro, l'accertamento della natura subordinata dei loro rapporti di lavoro o, in alternativa, la declaratoria della sussistenza di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 DLgs n. 81/2015;
Il Tribunale dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire, ai sensi del cit. art. 2, la retribuzione diretta, indiretta e differita prevista dal CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (applicato dalla società ai propri dipendenti), nonché il loro diritto all'inquadramento nel VI livello, e condannava la medesima società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
In appello i Giudici rigettavano il gravame interposto dalla datrice di lavoro, affermando, a sostegno della propria decisione:
- la natura esclusivamente personale della prestazione, ratione temporis richiesta dalla norma, non è esclusa dall'uso di un mezzo proprio (bicicletta o scooter), poiché tale requisito va inteso come assenza della possibilità di avvalersi di propri ausiliari (Cass. n. 1663/2020);
- inoltre, con l'art 2 del DLga n. 81/2015 il Legislatore ha inteso agire non solo sul piano della prevenzione delle elusioni, ma pure su quello rimediale, al fine di assicurare al lavoratore la protezione propria del lavoro subordinato nel caso in cui si trovi ad operare in una "zona grigia" fra autonomia e subordinazione;
- in ogni caso è il rider ad impiegare il mezzo, non il mezzo a svolgere autonomamente la prestazione, ossia, nel condurre la bicicletta o il motociclo il rider concorre a determinare il tempo di consegna, coessenziale al l'adempimento della prestazione, sicché l'impiego del mezzo non fa venire meno il carattere personale della prestazione;
- il requisito della continuità deve essere valutato in senso ampio e nella specie ricorre, considerato che i contratti di collaborazione avevano una durata di alcuni mesi, considerato peraltro che tale durata era prevista in contratti di lavoro autonomo sicché non può rilevare quella nozione di continuità tipica del lavoro subordinato;
- considerata la peculiarità dell’organizzazione del servizio di consegna gestito dalla società, la continuità va intesa in senso giuridico come disponibilità del collaboratore a rendere la prestazione, sicché deve essere commisurata non alla media dei turni in concreto effettuati su base mensile, ma al numero di turni che ciascun lavoratore ha opzionato, poiché il contratto prevedeva la facoltà del dispatcher di opzionare un altro rider, diverso da quello che si è candidato per la consegna, per le ragioni più disparate;
I numeri evocati dalla società appellante, dunque, non rilevano al fine di dimostrare l'occasionalità della prestazione.
Sono caratterizzanti gli aspetti dell'etero-organizzazione dell'attività del servizio di consegna, che, per il tramite di piatteforme digitali, è risultata estranea ai riders perché completamente riservata e decisa dalla società appellante.
Taluni elementi del rapporto di lavoro dei riders valgano solo a confermare l'autonomia del lavoratore nella fase genetica, non mettono in dubbio il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione, determinante ai fini della riconduzione del rapporto alla fattispecie di cui aII'art. 2 del DLgs n. 81/2015.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte si è occupata per la prima volta dei riders nella sentenza n. 1663 del 2020, evidenziando che l'art. 2 del DLgs n. 81/2015 non introduce una nuova fattispecie, un tertium genus fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, bensì una "norma di disciplina", volta (e limitata) a dichiarare applicabile la disciplina della subordinazione a rapporti di lavoro che possono legittimamente essere pattuiti come di lavoro autonomo.
Pertanto - sostengono gli Ermellini - gli argomenti utilizzati dalla ricorrente per escludere il requisito dell'esclusiva personalità della prestazione lavorativa si rivelano infondati e comunque irrilevanti. In tal caso, la proprietà del veicolo utilizzato per eseguire la prestazione e i relativi costi di eventuale manutenzione sono e restano ovviamente del collaboratore proprio perché il rapporto di lavoro resta qualificabile giuridicamente come di lavoro autonomo. Ma tale profilo attiene - continuano i Giudici - alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, non alla disciplina applicabile. Questo stesso aspetto è pertanto irrilevante ai fini dell'art. 2, che, in considerazione di determinati elementi, ha appunto la funzione di dichiarare applicabile la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che ben possono essere configurati dai contraenti come di lavoro autonomo.
Ne deriva che, in modo conforme a diritto, la Corte di appello ha ritenuto che il requisito in esame - ossia il carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa - potesse essere negato solo in presenza dell'eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi di propri ausiliari, facoltà esclusa all'esito del compiuto accertamento di fatto.
Nell'art. 2 il medesimo Legislatore postula che il rapporto di lavoro possa essere di natura autonoma, soltanto che, in presenza di determinate caratteristiche concorrenti, ritiene necessario assoggettarlo alla disciplina di tutela propria del lavoro subordinato.
E ciò che connota specificamente questa "norma di disciplina" è - in concorso con la continuità e con il carattere personale della prestazione lavorativa - soprattutto il requisito dell'etero-organizzazione. Quest'ultimo, infatti, è apprezzato come idoneo a distinguere l'ambito di disciplina (sostanziale) del lavoro autonomo dall'ambito di disciplina (sostanziale) del lavoro subordinato, che ricomprende non soltanto i rapporti di lavoro qualificabili come subordinati, ma altresì quelli giuridicamente di lavoro autonomo che tuttavia risultino connotati dall'etero- organizzazione, oltre che dalla continuità e dal carattere personale della prestazione.
Peraltro, il carattere della continuità risulta specificamente pattuito fra le parti al momento iniziale del rapporto, avendo la Corte territoriale accertato che i contraenti hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e, appunto, continuativa.
Peraltro, i Giudici d'appello, ai fini del proprio convincimento sulla sussistenza della continuità, hanno riconosciuto rilevanza non solo alla quantità di tali turni in concreto opzionati, ma anche alla facoltà datoriale di scegliere comunque un rider diverso da quello che pure offriva la propria disponibilità per quella specifica consegna.
Quanto alle modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione.
Può essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa.
di Francesca Esposito
Fonte normativa